È in atto da venerdì una shitstorm su #PropagandaLive dovuta al boicottaggio della trasmissione da parte di Rula Jebreal, invitata a parlare della questione IsraeloPalestinese. Non entro nel merito della vicenda che potete approfondire direttamente sui social; quello che mi preme è cercare di analizzare la modalità dialettica in cui questa faccenda è montata. Cosa sia stato messo in discussione, in che modo e attraverso quale lessico.
La questione sollevata dalla Jebreal è sensata? Sì, lo è. Esiste un problema di sottorappresentazione di genere nell’etere, ed è un retaggio di un modello maschilista – in Italia le donne votano dal 1946; grazie alle lotte per l’autocoscienza e autodeterminazione (partite a inizio novecento ed esplose nella seconda metà del secolo) la società maschiocentrica è però in profonda trasformazione, con andamento esponenziale.
È stato giusto usare PropagandaLive come esempio di manel, mansplaining, e compagnia cantando? No. Perché i contributi del programma sono da sempre centrati sulla rappresentanza delle diversità, e nessun altro programma si avvicina al taglio critico e approfondito sul tema dell’integrazione, dei diritti e delle pari opportunità. Se Bianchi ammette che c’è ancora strada da fare – con otto anni di programmazione centrati su questi temi, viene attaccato come un “maschio bianco che fa mansplaining”. Questa cosa non è accettabile (nei modi e nei contenuti), perché risponde ad una logica binaria e polarizzata, che tende alla collezione di reactions più che alla costruzione di una dialettica.
Ma questa modalità polarizzata è vincente? Sì, lo è. Perché obbedisce al principio (algoritmico) della riduzione del conflitto a scontro, e conduce le parti in causa ad un atteggiamento fideistico e non critico, supportato da un lessico polarizzante che fa la fortuna dei pollai social, un “non-confronto” fondato sul “non-riconoscimento” tra parti, con il coinvolgimento di “seguaci” che si coagulano – acriticamente – attorno alle proprie Api Regine. In questo modo si generano traffico ed engagement, alla faccia della disparità di genere che diventa un hashtag, invece che un tema pubblico – e NON è la stessa cosa (vedasi in tema l’attuale sistema di selezione della classe dirigente).
Vabbeh, ma il problema qual è? Il problema è che il mondo informatizzato sta generando un cambiamento radicale nel rapporto che lega l’essere umano con il suo pensiero. La visione “algoritmica” della realtà fa perdere la messa a fuoco dei dettagli, delle pieghe del ragionamento critico e favorisce prese di posizione apodittiche, trovando sempre una giustificazione all’approssimazione con cui esse si formano. Non importa conoscere una trasmissione, mi basta vedere una foto di lancio su Twitter. Non è importante analizzare una battaglia di rappresentanza, mi accontento di vedere una foto di Rula Jebreal con Weinstein e applicare un nego maiorem a qualsiasi ragionamento che provenga da lì. Ed ecco che la dialettica si fa polemica, e la polemica si fa reciproca cancellazione. Si litiga negando all’interlocutore la possibilità di avere delle ragioni. Quindi diventa un dialogo tra sordi incattiviti e pilotati da un giustizialismo catodico che altro non è che la traduzione in sensazioni fisiche del social reward, il premietto che ci aspettiamo per aver dato in pasto all’algoritmo parte della nostra emotività. E così a catena e all’infinito, perché il Deep Learning non si stanca mai di tracciare, triggerare, ingaggiare, profilare.
Ma i rischi quali sono? I rischi sono sul lungo periodo. Dato il combinato disposto tra nuove tecnologie, abitudini che ne derivano e consuetudini sociali che si radicano, la costruzione della sfera empatica dei nativi digitali sta subendo un mutamento i cui effetti non saranno misurabili finché non saranno cresciuti. Al momento, abbiamo in auge una tendenza ai processi sommari e alla gogna mediatica che fa paura, specie nei confronti delle minoranze (si vedano le tempeste d’odio nei confronti dei genitori omosessuali, o ai naufragi nel Mediterraneo: tutti esempi che parlano di una galoppante incapacità di articolare un ragionamento sulla base della capacità di mettersi nei panni di qualcun altro). La questione è sul ricambio generazionale; cosa accadrà quando la totalità degli appartenenti alla società saranno nati e cresciuti sotto questo sistema egemonizzato da un linguaggio a misura di macchina?
La giornata mondiale della celiachia: cosa c’entra? Quando l’industria del cibo è esplosa, a partire dagli anni settanta del novecento, i grani usati per fare la pasta hanno cominciato ad essere selezionati NON sulla base della loro digeribilità, ma bensì a partire dalla consistenza e dalla forza delle farine che andavano scelte in base alla loro efficienza con le MACCHINE che le lavoravano. Quindi, grani molto più ricchi di glutine in quanto più modellabili dai macchinari dei pastifici. Dopo una quarantina d’anni (facciamo cinquanta? Facciamo cinquanta!) il numero dei celiaci – cioè degli ammalati di un’infiammazione cronica dell’intestino scatenata dal glutine – è in aumento costante. Io non ho i titoli e le competenze per scrivere uno studio in merito, ma quello che mi preme sottolineare è che la salute umana, in un sistema come il nostro, viene dopo il profitto. E il nostro engagement sui social vale moltissimi soldi. Il punto è che mentre facciamo guadagnare chi ha messo in piedi questo sistema che colonizza le nostre teste, noi rinunciamo all’esercizio del pensiero critico (poco monetizzabile) e perdiamo progressivamente la capacità di dialogo, sostituendola con la comunicazione basata sulle “reactions”. Quindi reagiamo a degli stimoli verbali, invece di costruire senso. Usiamo i binari della comunicazione digitale senza interrogarci su CHI li abbia piazzati, e – soprattutto – perché. Così facendo, l’unica cosa certa è che generiamo reddito per qualcuno che non conosciamo mentre miniamo le fondamentali abilità del nostro cervello, sostituendole con dinamiche meno razionali e più animali (la logica delle reactions, appunto: avete presente Pavlov? Quello, però 2.0)



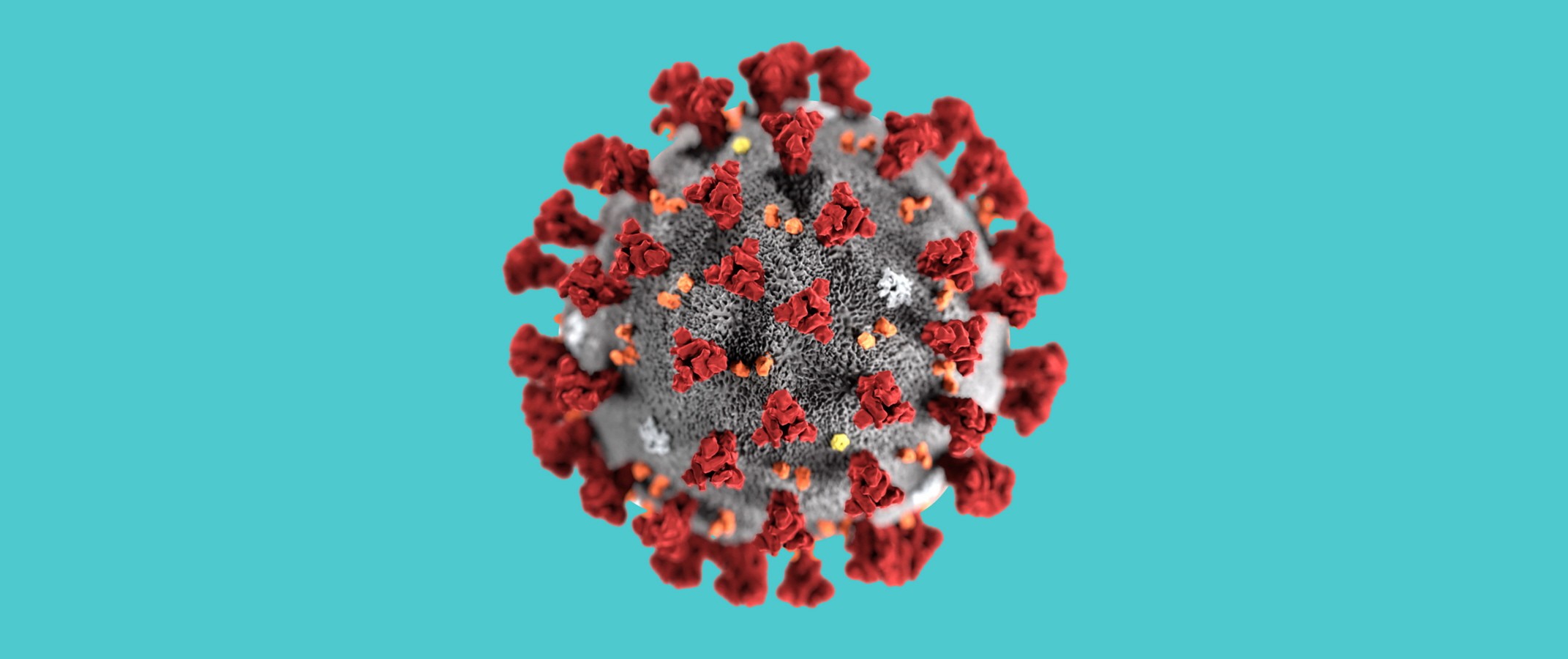
Scrivi un commento